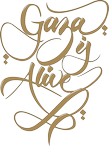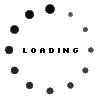È arrivato il momento di tirare le somme del nostro progetto e lo facciamo appena rientrati, quando le nostre tantissime emozioni sono ancora calde.
Lo premettiamo subito, a scanso di equivoci: Gaza è un posto complesso in cui convivono mille contraddizioni, tantissimi problemi, drammi e difficoltà. Forse è questo il primo sentimento che ciascuno di noi ha provato quando siamo entrati all’interno della Striscia.
Certo, potrebbe sembrare un’ovvietà, siamo ormai abituati alla narrazione di Gaza proveniente dai media. Una narrazione che si preoccupa di quel fazzoletto di terra solo quando accade qualche fatto di sangue.
Ma Gaza è Viva, brulica di un’intensa vitalità che è difficile raccontare attraverso poche parole da condividere online.
La quotidianità di Gaza ci ha stupito, ci ha ammaliati, spaventati, talvolta ci ha reso la vita complicata ma sopratutto ci ha immediatamente fatto rendere conto che tutto quello che sapevamo sulla “più grande prigione a cielo aperto” era solo un acquerello della realtà.
Sapevamo dell’assedio israeliano, che costringe i gazawi a vivere come in una gabbia: senza poter uscire né via terra, né via cielo né tantomeno via mare. E anche noi abbiamo sentito, nonostante la breve durata del progetto, quel senso di prigionia con cui gli abitanti della Striscia convivono quotidianamente.
Ma la scorza dei palestinesi è dura, ne hanno dato ampia dimostrazione nel corso degli anni.
Non saranno certamente i muri e le navi da guerra a rubare la vita a Gaza. Certo, la continua pressione psicologica a cui sono sottoposti i gazawi evidentemente sta portando la situazione al collasso, nessuno può sopportare a lungo questa condizione.
E a farne le spese sempre sono i bambini e le bambine, costretti a trovare il modo di sopportare la guerra, le bombe, la povertà, le condizioni socio-economiche al limite.
Questo è esattamente quello che abbiamo trovato al nostro arrivo a Gaza.
La situazione ci ha fatto immediatamente rendere conto che la nostra missione, provare ad alleviare le sofferenze dei giovani attraverso la cultura Hip Hop, sarebbe stata decisamente più ardua di quanto avevamo immaginato scrivendo il progetto su freddi fogli di carta.
Ma le speranze non avrebbero tardato a palesarsi: sotto forma di una crew, i Camps Breakerz di Nusseirat, ad esempio. Una realtà che lavora in un territorio difficilissimo, un campo profughi della striscia, a contatto con la periferia.
Un esempio di determinazione, forza e coraggio che ha saputo ritagliarsi uno spazio in mezzo ai pregiudizi culturali di questa terra.
Ballare la breakdance lì è un atto di estrema forza, un’azione di rottura della quotidianità e della paura.
Grazie alla CB Crew siamo riusciti a coinvolgere decine di ragazze e ragazzi in questo progetto: supportare la scena Hip Hop e, al contempo, valutare gli effetti delle discipline dello stesso sulla salute mentale di chi ha partecipato ai nostri workshop.
Abbiamo dovuto superare le prevedibili resistenze culturali di chi ha ritenuto che il nostro progetto “potesse essere in contrasto con la cultura locale”, dimostrando che l’Hip Hop in fondo è un linguaggio il cui unico limite è la fantasia di chi lo pratica. Mai come in questo caso il termine “evasione” può apparire azzeccato.
Abbiamo sempre considerato questa esperienza come un progetto pilota, per provare ad affinare un metodo di lavoro unico. Sappiamo quanto la musicoterapia sia uno strumento potente ed efficace. Ma cosa accade quando la questa incontra le discipline dell’Hip Hop?
Cosa accade quando i ragazzi utilizzano la danza, il canto e il disegno, sentendosi parte di una comunità globale? Abbiamo creduto in questo sogno e l’abbiamo, giorno dopo giorno, realizzato.
Per questo durante tutte le giornate di workshop abbiamo dato grande rilevanza all’ambito psicologico del progetto. Grazie alla letture collettive delle favole siamo riusciti a entrare in empatia coi ragazzi, cercando di capire quali fossero i problemi e le paure di un giovane costretto a convivere con una guerra continua.
Quello che volevamo dal progetto ci è stato chiaro fin dall’inizio, così come ci era chiaro quello che Gaza is Alive non voleva essere: un evento singolo, un atto di pur necessaria compassione.
Volevamo, e lo vogliamo ancora ora che il nostro cuore pulsa per le fortissime emozioni vissute, che fosse invece l’inizio di un lungo percorso che continui anche adesso che siamo tornati a casa.
L’arte si è dimostrata in ogni workshop fondamentale per una crescita a vista d’occhio dei ragazzi.
E non parliamo soltanto dei tanti “potenziali talenti” che finalmente hanno potuto esprimersi. Parliamo di quella crescita nella vita di ogni giorno che permette a ciascuno di portare a casa un miglioramento della propria condizione grazie al supporto delle proprie passioni.
Per noi vivere la quotidianità di Gaza ha significato pure dover assistere a una serie di bombardamenti in una zona vicina al nostro alloggio. Anche noi abbiamo vissuto la paura, la tensione, la rabbia di essere spettatori, comunque privilegiati, di uno spettacolo che inevitabilmente ti segna: i bombardamenti.
E non siamo riusciti a metterci nei panni di chi le bombe le subisce ogni giorno. Non siamo riusciti a immaginare come ci si possa sentire in una striscia di terra circondata da un muro, con centinaia di navi da guerra sempre lì, proprio sulla linea dell’orizzonte, messe apposta per ricordare ai gazawi che la speranza di uscire da quella terra è solo un’illusione.
Non siamo riusciti ad abituarci al ronzio costante dei droni sopra la nostra testa, al rombo degli F-16 che preannuncia un messaggio di morte e distruzione.
Non saremmo mai riusciti a farci forza se non l’avessimo presa in prestito dai nostri ragazzi, sempre sorridenti, carichi e interessati. Era questa la nostra cartina al tornasole: il metodo ha funzionato.
E non abbiamo problemi ad ammetterlo, ha funzionato oltre le nostre aspettative.
Siamo partiti per insegnare qualcosa, ma in realtà anche noi abbiamo imparato delle lezioni che porteremo con noi per sempre.
Ci hanno spiegato che non è il suono dell’esplosione a fare paura, ma il rumore del missile in picchiata, che potrebbe cadere ovunque e renderti un bersaglio.
Ci hanno insegnato che allenare il proprio corpo a sfidare la gravità è una sorta di messa alla prova che fa bene non solamente al fisico, ma soprattutto alla mente.
Ci hanno spiegato che il razzismo non ha senso di esistere, che quando c’è una cerimonia importante un terzo della ricchezza va condivisa con chi è meno fortunato, che quando cadono le bombe ci si raduna tutti nella casa di chi in quel momento si trova nel luogo più sicuro.
L’hanno fatto con semplicità, comunicando a volte con le parole, ma più spesso con i gesti. Tanti piccoli dettagli che normalmente ci sfuggono nella frenesia della vita all’occidentale sono emersi stando a contatto con i giovani gazawi: si condivide tutto con i propri pari, in primis i pensieri e le emozioni, perché solo in questo modo ci si tutela dalle infinite trappole.
E ci hanno anche messi di fronte al fatto che tante azioni che per noi sono la normalità, ci rendono solamente più individualisti, come ad esempio l’insensatezza di scrivere il proprio nome sul bicchiere di plastica, tanto si prende sempre quello che sta più in alto nella pila.
Sta tutto negli occhi di quei ragazzi all’inizio della giornata.
È vero, alla fine del pomeriggio sarebbero tornati alla vita reale, fatta di violenze e povertà, ma l’avrebbero fatto con una coscienza nuova.
Per questo, con il supporto del rapper Ayman, della CB Crew, del writer Yazid, del PCRF e di altri artisti locali, vogliamo che le attività continuino per i prossimi mesi.
Siamo andati via con la speranza di aver lasciato il segno, coscienti che un progetto così complesso richiederà un lavoro a lungo termine, per questo avremo bisogno del vostro supporto.
Perché Gaza è Viva, è arrabbiata, è felice. E noi saremo di nuovo lì l’anno prossimo, con la speranza che quella vita, quella rabbia, quella felicità possa essere domata a suon di rap, dai movimenti veloci della breakdance e che possa essere espressa in tutti i muri di Gaza sotto forma di graffiti.